Stefano Pasta, autore di Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell’odio online, Scholé-Morcelliana, 2018 fa parte del Centro di Ricerca sull’Educazione ai media dell’Informazione e alla Tecnologia - CREMIT e del Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali. Gli abbiamo chiesto di approfondire alcuni aspetti del suo lavoro, che indaga e spiega dinamiche e aspetti dei fenomeni di razzismo, utili anche agli insegnanti che si misurano quotidianamente con fenomeni di razzismo e bullismo anche legati al web.
‘Hate speech’ (non solo discorsi ma anche atteggiamenti), disposizioni e consapevolezze interiori contribuiscono a costruire l’odio 2.0. Come fanno gli insegnanti ad affrontare razzismo, bullismo e prevaricazione negli studenti?
Lo «speech» non va inteso solo come “parlare”, ma tutte quelle modalità espressive della persona che ledono la dignità umana. Secondo il Consiglio d’Europa è “comprensivo di tutte le forme di espressione miranti a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio fondate sull’intolleranza, tra cui l’intolleranza espressa sotto forma di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone di origine immigrata”.
Quanto all’ambiente digitale, Internet costituisce un esempio di fare “cose con le parole”, quella dimensione performativa (o perlocutoria) del linguaggio che consiste nell’andare oltre la possibilità di descrivere le cose per pensare il dire come forma di agire comunicativo. L’intera retorica della comunicazione in Rete è in qualche modo costretta a surrogare le varie forme del fare attraverso il dire (anzi, il cliccare, lo scrivere, il postare): fare cose con le parole e altri segni grafici, in Internet, non è una scelta, ma una necessità. Inoltre, l’affermarsi del Web 2.0 e dei social network ha messo a fuoco la natura sociale della Rete come luogo della società e non spazio esterno a essa.
Il titolo del libro, Razzismi 2.0, è al plurale: le manifestazioni e le intenzionalità di chi agisce l’hate speech sono diverse. Durante la ricerca, ho chattato con ragazzi con un’adesione ideologica strutturata e con altri – molti di più – che ripetevano “mi stai prendendo troppo sul serio”, “ho fatto solo una battuta”. Ma la posta in gioco è seria: sono giovani che inneggiano allo stermino, invocano le molotov contro i profughi, commentano un gol usando “ebreo” come parolaccia e scherzano sulla Shoah, minacciano di stuprare una coetanea che non la pensa come loro. Spesso l’odio elegge a bersaglio più target allo stesso tempo: quando si prende di mira una donna perché africana, o in quanto accusata di essere a favore degli stranieri, scatta facilmente l’insulto sessista o contro i disabili.
Inoltre, l’hate speech – e ancora di più i casi segnati da superficialità e provocazione – appartiene a quello che Marc Prensky, nel 2011, ha chiamato cyberstupidity. Indica tutti i comportamenti nel Web per i quali gli autori non valutano le conseguenze delle loro azioni. In questo senso, cyberbullismo e sexting appartengono allo stesso spettro di comportamenti. Una risposta a cui possono tendere le insegnanti è l’educazione alla responsabilità, che il Miur ha posto alla base del Curriculum di Educazione Civica Digitale, emanato nel 2018 e organizzato in aree come educazione ai media, educazione all’informazione, creatività digitale.
La Rete fotografa le espressioni, ma qua fuori le parole scorrono. Quanto pesa Internet nel rafforzamento delle dinamiche di odio?
La Rete è vita reale, è realtà aumentata. Online e offline hanno caratteristiche diverse, ma si agisce in piena continuità. Gli episodi di giovanissimi suicidatisi perché presi di mira nel digitale mostrano che è una continuità di piena realtà: esiste qualcosa di più reale che togliersi la vita? Tuttavia, è diffusa l’idea – forse perché inconsciamente pensiamo che la Rete non sia così reale – per cui nel Web ci si possa comportare in modo deresponsabilizzato, meno attento e più superficiale.
Tutto ciò ha una conseguenza anche sui contenuti: “torna la razza”. Un’immagine simbolo della mia ricerca è una donna africana paragonata alla scimmia, facendo una battuta (magari sessista). Si tratta dell’emblema del razzismo classico, che forse pensavamo scomparso, seppur svuotato di credibilità e su basi diverse dal suo significato storico. È un grande cambiamento: la prima parte del Novecento era segnata dall’istanza biologica, la superiorità dei bianchi sui neri; 80 anni fa, le Leggi Razziste fasciste furono accompagnate da testi accademici che sostenevano il razzismo su basi (pseudo)scientifiche. Sempre la letteratura ci dice che, nel Secondo Novecento, acquista importanza la logica culturalista o differenzialista (quando si sostiene che i valori di un’etnia, o di una religione, sono troppo diversi dai nostri per vivere insieme) e i razzismi impliciti o latenti. Oggi emerge una novità: online diventa molto più labile la separazione tra razzismi espliciti e latenti, superata tra link, “mi piace”, meme e immagini, evocazioni e condivisioni. Con il linguaggio violento sono caduti alcuni tabù (parole e pensieri che, insieme, avevamo deciso che fossero “indicibili”). La banalizzazione e la deresponsabilizzazione nel Web hanno reso possibile quel processo di accettazione sociale che, ad esempio, ci porta a non essere più scandalizzati dell’associazione tra uomo nero e scimmia, o che la pagina social di una donna sia ricoperta di insulti e minacce di stupro
Internet è apparentemente la realtà del non-potere, orizzontale e paritaria. Ma la libertà consiste soprattutto nell’accettazione di qualche regola…
Il Web è il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia conosciuto. Va inteso come un potenziale strumento e spazio di libertà, ma non è aprioristicamente libero. Dipende dall’uso che ne facciamo: lo può essere, come quando i social hanno avuto un ruolo decisivo nelle Primavere Arabe del 2011 o quando il digitale permette di aggirare le restrizioni di un regime dittatoriale. D’altro canto, non è vero che in Rete “uno vale uno”. Con un approccio “umanamente ragionevole” e di rifiuto della polarizzazione tra tecnofili e tecnofobi, eventuali regolazioni non sono un attentato alle presunte libertà e neutralità della Rete, piuttosto come un auspicio verso la costruzione del Web “costituzionalizzato”, all’interno del quale si colloca anche la riflessione sull’hate speech. In questo modo usciamo dalla strettoia del dividerci tra “apocalittici” e “integrati” di fronte al Web. È un rischio che sempre si corre quando si diffonde un nuovo media e, non a caso, ho citato un’espressione del 1964 di Umberto Eco riferita alla televisione. La risposta della media education, per una postura intelligente davanti allo schermo televisivo, fu l’educazione al senso critico. Nel digitale questo non è più sufficiente, perché rappresenta solo la metà dell’opera. Non basta più educare lo spettatore, occorre anche educare il produttore che ogni spettatore è diventato grazie allo smartphone che si porta in tasca. Questo significa che insieme al pensiero critico occorre sviluppare anche la responsabilità.
Educare alla responsabilità vuol dire affrontare, da un punto di vista educativo il tema della “libertà”. Che cos’è la libertà? La possibilità “di dire quello che si vuole”, potenziale premessa a un discorso d’odio e di discriminazione. Va invece affermato il concetto di libertà positiva proposto da Martin Buber, una “libertà di” essere persone inserite in un contesto, persone in grado di esprimere una propria idea, aperte all’incontro con l’altro, in relazione con le opportunità che offre la società circostante, compresa quella aumentata del Web. Spiega Buber: “Si tende a considerare questa libertà, che si può chiamare evolutiva, come opposto della costrizione, dell’essere-obbligati-a. Ma l’opposto della costrizione non è la libertà, bensì lo sperimentare un legame. La costrizione è una realtà negativa, sperimentare un legame è una realtà positiva. La libertà è una possibilità, la possibilità riconquistata. Essere costretti dal destino, dalla natura, dagli uomini: il suo opposto non è essere liberi dal destino, dalla natura e dagli uomini, bensì essere legati e alleati al destino, alla natura, agli uomini”. In quest’idea di libertà della Rete, intesa come possibilità a cui tendere e non come assunto aprioristico, vi è dunque la base di un serio progetto che unisca educazione alla cittadinanza interculturale ed educazione alla cittadinanza digitale.
Là dove nasce un problema nasce la soluzione, è così?
Potremmo dire, con Hölderlin, che “là dov’è il pericolo cresce anche ciò che salva”. Al tempo dell’hate speech, diviene virale anche un altro tipo di manifestazioni: un hashtag che, nato in modo spontaneo, diviene trend topic su Twitter per contrastare l’errata associazione tra musulmano e terrorista; il gesto di un calciatore che si trasforma in una campagna su Facebook contro l’ennesimo gesto razzista; la mobilitazione che, a colpi di click, ottiene la chiusura di una pagina di incitamento all’odio; un adolescente pachistano difeso da alcuni coetanei dopo tanti insulti ricevuti.
Sono dunque altrettanto reali gli “anticorpi”, performances antirazziste, narrazioni alternative, singoli o gruppi che reagiscono di fronte all’elezione di un bersaglio. Media education significa anche valorizzare la “saggezza della folla” e attivare gli utenti del Web al fine di costruire una narrazione alternativa. Un capitale da non sprecare: se correttamente coinvolti, i ragazzi mostrano disponibilità al confronto con l’adulto, non si sottraggono al dialogo, sono pronti a disporsi in modo proattivo e accettano di partecipare, gratuitamente, a campagne con l’obiettivo che un quindicenne, di cui riporto la conversazione nel libro, ha riassunto con lo slogan «il bene trionferà»
La sanzione sociale del razzismo esplicito ha storicamente pesato nel renderlo implicito?
Dopo Auschwitz, le società europee hanno eretto un muro morale di fronte alla discriminazione e il razzismo esplicito, biologico. Le logiche di gerarchizzazione e differenziazione, alla base dei razzismi, non sono estinte, ma hanno assunto nuove modalità. È in corso un processo che sta portando alla caduta di quel muro, dei tabù culturali verso il razzismo. La Rete precorre l’offline: l’assenza di una regolamentazione appropriata lo facilita, ma tale mancanza non è la spiegazione di un fenomeno che invece ha radici morali. Se l’accettabilità sociale verso i razzismi è in crescita, il lavoro educativo deve andare oltre il confronto tra diversi, ma affrontare in maniera più esplicita la concezione, alla base della morale e dei razzismi stessi, di “cosa sia buono” e “cosa sia male”, giusto e ingiusto. Vi è la necessità di sviluppare riflessività, una condizione per scelte responsabili, senza trascurare, come avviene nell’etica formale, l’incisività delle situazioni concrete e degli aspetti affettivi. Durante la ricerca ho svolto diverse conversazioni, via social network, con ragazzi che avevano partecipato a performances d’odio: ho cercato di trasformarli in “agenti morali”, imparando a dire “io” in modo serio davanti alle scelte e soprattutto di fronte agli altri. Secondo Zygmunt Bauman, la responsabilità morale è la più personale e inalienabile delle proprietà umane, e il più prezioso dei diritti umani. Questa accezione di responsabilità personale, frutto dell’educazione, è appresa dal singolo verso ciò che Lévinas chiama il “volto dell’altro”, in quanto l’io assume un obbligo nei confronti dell’altro in una concezione della responsabilità essenzialmente relazionale, “essere responsabili di”.
L’ironia può agire nella normalizzazione del razzismo. Quali sono i “campanelli d’allarme” che ci aiutano a prevedere le conseguenze dei nostri atteggiamenti?
L’ironia in sé può essere un’alleata del pensiero razzista, perché facilità la pretesa di non essere presi sul serio e permette di rompere i tabù sociali. D’altro canto può essere uno strumento con cui contrastare il discorso razzista. Un campanello d’allarme è sicuramente l’incipit “non sono razzista ma”: nel momento in cui lo utilizziamo, sentiamo la necessità di autoassolverci poiché stiamo infrangendo un tabù morale. Anche la critica al politicamente corretto è un’altra spia di un potenziale discorso che libera la parola, infrangendo un tabù sociale concordato.
Che cosa è il paradosso dei nativi digitali e interculturali?
Non basta nascere in società multiculturali e multischermi per essere “nativi digitali” o “nativi interculturali”: si può vivere accanto a persone di origine diversa senza incontrarle veramente, così come la ricchezza polifonica offerta da Internet per connettersi al mondo può rimanere chiusa in uno spazio individuale, senza mettere in gioco una relazione tra gli interlocutori. “Nativi digitali” è una fortunata espressione lanciata dall’americano Marc Prensky nel 2001, indicando una presunta analogia tra l’apprendimento della lingua materna e il mondo digitale: secondo quest’ottica i bambini svilupperebbero una particolare dimestichezza con le tecnologie non condivisibile dall’adulto (immigrato digitale), che al contrario potrebbe raggiungere una buona padronanza ma mai un legame paragonabile a quello dei nativi. Quella metafora aprì un lungo dibattito che portò lo stesso Prensky nel 2011 a ripensare alla vera differenza non più su un piano generazionale tra nativi e immigrati, ma tra il “saggio digitale” e il “cyberstupido”. La vera differenza la fa l’educazione, non l’età. Occorre sempre più interrogarsi sulle logiche, più che sulle tecnologie. Facendo un esempio da aula scolastica: non solo saper accendere la lim, ma soprattutto educare all’informazione e a comunicare online in modo corretto. È vero che un bambino impara, vedendo il genitore, fin dall’infanzia a sbloccare lo schermo del cellulare (e magari tenta di sfogliare il libro con lo stesso gesto dell’indice), ma la competenza non è solo quella tecnica, occorre saper riconoscere le fake news e selezionare le fonti. La competenza digitale, dunque, non è solo una conoscenza tecnica, ma una parte imprescindibile dell’educazione alla cittadinanza. Vivere insieme è la sfida che nel libro unisce l’educazione interculturale alla media education, nell’affermare il valore della responsabilità verso gli altri e nell’appassionata ricerca di una faticosa convivenza tra persone e tra cittadini, tutti uguali e tutti diversi.
Primo Levi: «Da molti segni, pare che sia giunto il tempo di esplorare lo spazio che separa (non solo nei lager nazisti!) le vittime dai persecutori». Che cosa accade in questo spazio grigio?
Una grande domanda viene da chi di fronte all’odio online non fa nulla, né intervenendo in modo diretto, né producendo discorsi o immagini alternative. Nel digitale i pubblici aumentano in modo esponenziale e dunque anche la “zona grigia”. Liliana Segre, parlando della Shoah, ha insegnato come l’indifferenza sia pericolosa e renda possibile il Male. In questo senso occorre spingere gli spettatori ad assumere il ruolo di soccorritori, processo che può essere facilitato proprio dalla cultura partecipativa della Rete.
Alcuni esperimenti, che riporto nel libro, mostrano come nei social network si è maggiormente sottoposti al desiderio di essere popolari, di essere apprezzati (con like e condivisioni), per cui diviene più difficile “uscire dai ranghi”, spezzando un coro d’odio quando è percepito come socialmente accettato. Di fronte alla Shoah, la riflessione intellettuale si è chiesto come sia stato possibile che tanti padri di famiglia tedeschi abbiano accettato di parteciparvi. Con tutte le differenze di proporzioni e distante storiche, ci potremmo chiedere come siano possibili alcuni coro di incitamento all’odio e allo sterminio di fronte ad alcune conversazioni.
Gli uomini non sono tutti uguali, ma tutti diversi. Milena Santerini ha proposto un’idea di cultura individuale, come il DNA. Promuoverla può contrastare l’odio 2.0?
Da Milena Santerini ho imparato che la cultura è dinamica, soggettiva e definita da tante sfaccettature. Cambia nel tempo, soprattutto a seguito degli incontri che ciascuno fa. Viene declinata dai singoli individui in modo personale e, quindi, il dialogo interculturale non si fa con – ad esempio – “la cultura albanese” o “i musulmani”, ma tra persone che, tra le varie caratteristiche, sono anche di una certa nazionalità e di una determinata religione. Ci siamo abituati a leggere tutto in chiave etnica, ma le categorie sociali, quelle di genere, i livelli di istruzione e tante altre caratteristiche possono essere altrettanto importanti. L’approccio interculturale supera la tensione tra universalismo e relativismo: guardando con simpatia alle diversità culturali, prova a trovare, con il confronto, dei valori condivisi per vivere insieme.
Gramsci indica la possibile formazione di un senso critico positivo attraversando la critica del senso comune. Per esempio, nel libro si cita “mogli e buoi dei paesi tuoi”: come può uno stereotipo che sembra innocuo innescare atteggiamenti di razzismo?
“Moglie e buoi dei paesi tuoi” è stata la risposta di un presunto “nativo digitale” in una delle conversazioni svolte via social network durante la ricerca. Come fonte autoriale citava la nonna. Questa affermazione dimostra che la dimensione online fa acquisire caratteristiche specifiche ai fenomeni di ostilità verso l’altro, ma non sono una cosa nuova. Nel libro sottolineo il ruolo delle pedagogie popolari implicite, radicate ormai in modo inconsapevole. È appunto la “pedagogia del senso comune”, o “senso comune educativo”, di cui parlava Gramsci, poiché assimilava il senso comune a una “filosofia spontanea” propria di tutti gli uomini, a un modo di pensare “disgregato e occasionale”, privo di “consapevolezza critica”, legato a una “concezione del mondo imposta meccanicamente dall’ambiente esterno, e cioè da uno dei tanti gruppi sociali in cui ognuno è automaticamente coinvolto fin dalla sua entrata nel mondo cosciente”. Il senso comune si riflette nel linguaggio, nelle immagini e nelle associazioni di pensiero che rispecchiano la concezione del mondo a cui tende la comunità educante. Per Gramsci il popolo da solo non è in grado di sviluppare sistematicamente una concezione del mondo, che è invece il compito della storia del pensiero filosofico (al contrario Dewey lo assegna alla scienza), ma il popolo può sviluppare la parte più “sana” del senso comune, quel “buon senso” che permette al proprio operare una dimensione consapevole, andando oltre le passioni immediate. È noto il ruolo attribuito da Gramsci agli intellettuali: attraverso un’elaborazione critica partono da concezioni diffusamente presenti (anche implicite) nella vita pratica, per elaborare una filosofia che, passando attraverso la critica di tali concezioni, sappia diventare “un rinnovato senso comune”. Scrive nei Quaderni dal carcere: «Creare una nuova cultura non significa solo fare individualmente delle scoperte “originali”, significa anche e specialmente diffondere criticamente delle verità già scoperte, “socializzarle” per così dire e pertanto farle diventare base di azioni vitali, elemento di coordinamento e di ordine intellettuale e morali».
Le pedagogie dell’odio caricano sull’Altro la funzione del Male, ma il concetto serve alla sopravvivenza delle specie: dove si pone il confine per pensarlo in modo antropologicamente evoluto?
L’identificazione del Male è una questione pratica, che si fonda sulla capacità individuale di formulare giudizi rispetto a ciò che si ritiene giusto o sbagliato in assoluto. L’essere umano, se vuole sopravvivere, non può fare a meno di elaborare questi giudizi. Si torna ancora una volta alla morale. Nell’evoluzione, due sono stati i momenti chiave che hanno indotto gli uomini a passare dalla cooperazione strategica alla morale genuina. Quando l’ambiente ha sfidato gli uomini a collaborare tra loro nella ricerca del cibo, i nostri antenati hanno sviluppato forme di intenzionalità congiunta che hanno dato origine a una prima forma di morale, basata sulla seconda persona. Poi la pressione demografica ha determinato la frammentazione in gruppi culturalmente definiti, le cui azioni hanno richiesto la formazione di un “noi” in grado di esercitare un’intenzionalità collettiva, creando norme che definissero cosa è giusto e cosa sbagliato. Il risultato è che gli uomini possiedono una morale che li obbliga nei confronti non solo degli altri individui, ma anche della comunità nella sua interezza.

Autore: Stefano Pasta
Prefazione di Pier Cesare Rivoltella
Postfazione di Milena Santerini
Titolo: Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell’odio online
Editore: Scholé-Morcelliana, 2018
L'intervista, realizzata nel 2018, è uscita nel precedente sito della Società Dante Alighieri. La riproponiamo per l'attualità del tema.
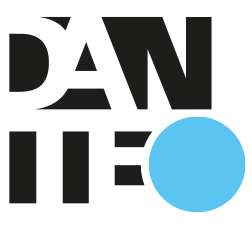



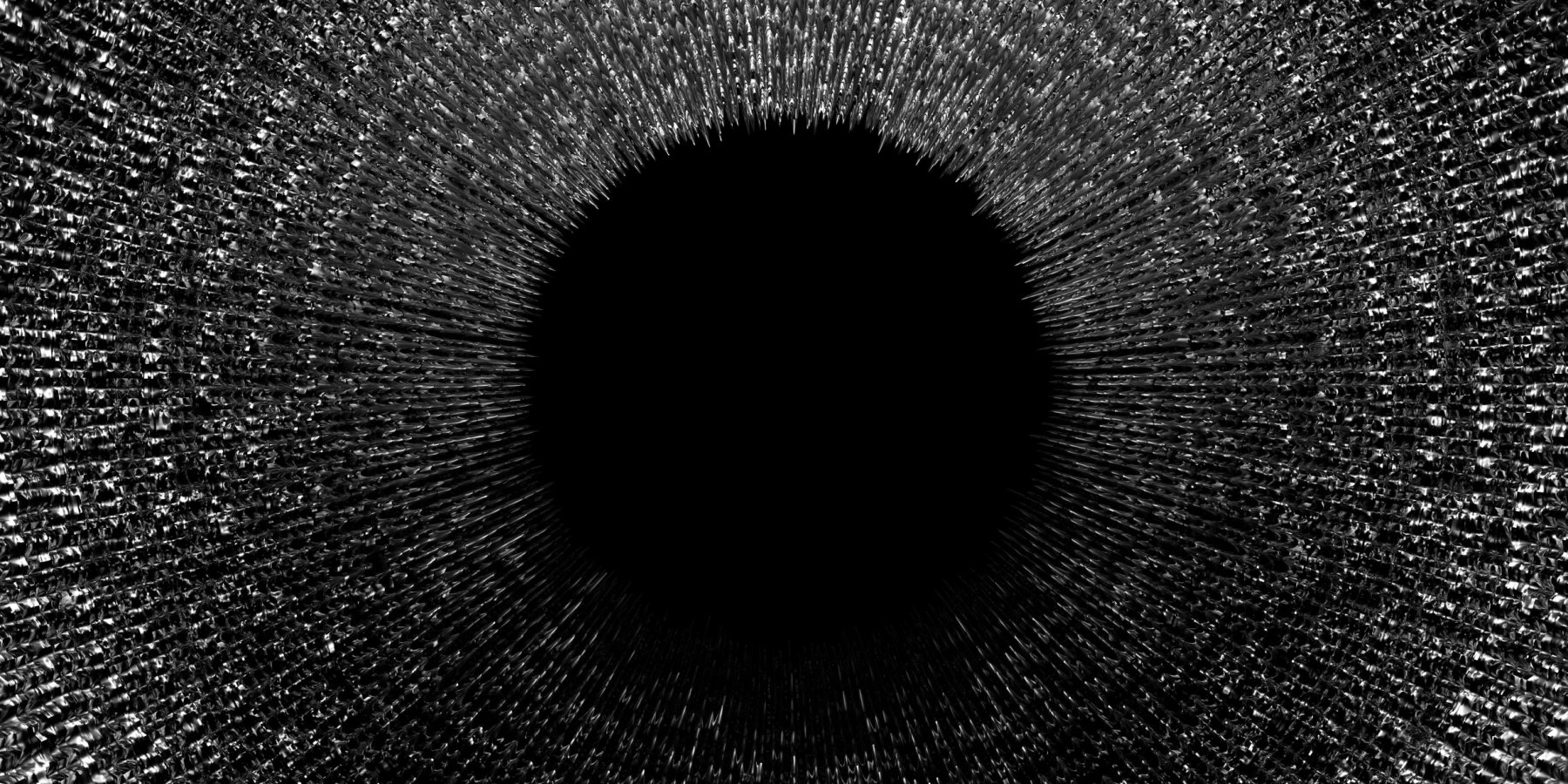









Commenti